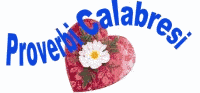|
|
© Copyright 2005-2021 by ViP ® L’altra Calabria
™ All right reserved ▲ |
|
|
|
Quei proverbi calabresi d’un tempo, sinonimo di saggezza popolare di Vincenzo Pitaro «L’ANTICU
‘ON SI SBAGGHJÀU!», si sente dire ancora oggi nei nostri paesi. E già da qui si
può intuire tutto: il popolo antico, bontà sua!, era un popolo di saggi. Una
saggezza popolare che trovava corpo nella tradizione orale, in quella che
oggi chiameremmo «letteratura sapientale», costituita da proverbi dialettali
e modi di dire. Considerati
la quintessenza del sapere, i proverbi riassumevano patrimoni di esperienze
in quanto erano frutto di vita vissuta, di abitudini, idee, credenze, ecc. Un’età
d’oro che pareva non avesse fine. In gran voga già dai tempi di Omero e di
Esiodo, di Orazio e Virgilio, i proverbi risultano diffusissimi anche nel
Medioevo e nel Rinascimento. In
Calabria, più o meno fino agli anni Settanta, era ancora possibile udirli,
tutti i giorni, nei discorsi che intraprendevano le persone di una certa età.
Oggi, che il mondo è mutato e continua a cambiare velocità, purtroppo
sembrano pressoché scomparsi. Quei pochi che paiono resistere ai tempi nuovi,
sono patrimonio degli anziani e rappresentano a tutt’oggi delle autentiche
miniere o giacimenti culturali in cui volentieri gli antropologi indagano per
cercare le origini di un popolo. Quasi
sempre conciso e breve, il proverbio (dal latino «verbum»: parola) aveva
molte forme metriche, dal settenario all’endecasillabo, e si differenziava
per la sua tipologia. C’erano i proverbi profetici («’U veru amicu si vida a
lu bisognu»), quelli antitetici (data la forma che opponeva due parti della
frase, come ad esempio: «Cu sapa ava centu occhj, cu ‘on sapa esta cecu»),
quelli metereologici («Pe’ tuttu maju non mutara saju»), i metaforici (con
doppio significato: «’A gatta prescialora fhàcia i figghji orbi»). C’erano
poi i proverbi cànone (tutti nella sfera della morale e del diritto: «Cu fha
pe’ idhu fha», gli alliterativi («Spusa, spisa»), i ritmici («Paga caru e
seda ‘mparu»), i blasonati, gli immaginari e via dicendo. Grazie
a un nostro accurato lavoro di ricerca su questo genere letterario, portato a
compimento dopo anni e condotto con pazienza quasi certosina, siamo
fortunatamente riusciti a recuperarne parecchi. Per
una questione di assonanza, se non proprio di metrica, alcuni ovviamente
meriterebbero qualche piccolo ritocco, proprio come farebbe oggi un pittore
sugli affreschi d’epoca, che ravviva i colori lasciando intatta l’immagine e
la sua freschezza. Tuttavia, abbiamo deciso di conservarli così come ci sono
stati tramandati, perché forse è in questo modo che i nostri emigrati, specie
quelli più in avanti con gli anni, amano ricordarli. Eccone,
comunque, una piccola carrellata, seguita dalla traduzione in italiano e da
qualche breve commento. ‘Ntra jennàru, vinu
bbonu e fhocularu (In gennaio,
vino buono e caminetto). Frevaru curtu e amaru
(Febbraio è corto ed amaro. «Amaro è colui che mi ha attribuito questo
appellativo», risponderebbe Febbraio secondo l’immaginazione popolare, «in
quanto sono proprio io che inizio alla fioritura tutti gli altri mesi che
verranno»). Cu a marzu ‘on puta ‘a vigna, perda tempu si’ vindigna. (Chi nel mese di marzo non si adopera nel lavoro
di potatura della propria vigna, rischia poi, in autunno, di non avere uva
abbastanza per vendemmiare). Non vala ‘nu carru e ‘nu carrili quantu n’acqua ‘e maju e dui d’aprili (Non vale un carro e un altro più piccolo messi
assieme quanto vale una pioggia nel mese di maggio e due precedenti piovute
in aprile). A giugnu non mi movu ‘e duva sugnu (Nel mese di giugno non mi muovo da dove sto). Sono tutti belli i
mesi in Calabria - come peraltro ci ricorda Leonida Répaci -, ma in giugno
sembra esserci qualcosa di straordinario, non si sa se un frutto o cos’altro,
che, secondo il proverbio, indurrebbe il calabrese a non partire e a godersi
ciò che offre questo mese. ‘On vitta mai ‘ntra lugliu nivicara e supa ‘u mara ‘mu quagghja la
nivi (Non ho mai visto nevicare
nel mese di luglio e neppure fare un piccolo strato di neve sopra il mare). Agustu è capu ‘e vernu
(Agosto è il principio dell’inverno). Settembra caddu e asciuttu, maturara fha ogni fruttu (un mese di settembre ben caldo e asciutto, fa
maturare ogni frutto). Ottobra cocia l’ovu (In ottobre
il sole può arrivare a cuocere finanche l’uovo). È una contraddizione
atmosferica che sottolinea come in agosto, a volte, può fare freddo e in
ottobre, invece, caldo. Si a novembra ‘on hai aratu, tuttu l’annu è malandatu (Se nel mese di novembre non hai lavorato la
terra, l’anno successivo renderà sicuramente poco). Ed
ancora: «Quandu arriva ‘a Candilora chjanta pipi e pumadora». In
concomitanza con la festa della Candelora (2 febbraio) il proverbio invita a
seminare o piantare peperoni e pomodori. Ce
n’è uno abbastanza bello, però, anche sui Santi. Sant’Andria porta la nova
ca ‘u quattru è de Varvàra, ‘u sia è de Nicola, l’ottu è de Maria, ‘u tricidi
‘e Lucia e ‘u vinticincu dô Veru Missia. Sant’Andrea apostolo,
fratello di San Pietro, che la Chiesa ricorda il 30 di novembre, è
considerato, nella civiltà contadina calabrese, colui che annuncia
ufficialmente l’arrivo delle festività in dicembre: Sant’Andrea porta la
notizia che il quattro è di Santa Barbara, il sei è di San Nicola, l’otto è
dell’Immacolata Concezione, il tredici di Santa Lucia e il venticinque del
Vero Messia. Fin
qui, dunque, i proverbi. Pochissimi, a dire il vero, per ragioni di spazio. Da
una nonnina calabrese, fra l’altro, abbiamo sentito declamare, non molto
tempo addietro, dei versetti antichi, che ci piace riportare perché denotano
in ogni caso la fierezza dell’essere calabrese. Su’ Calabrisi e Calabrisi
sugnu, su’ canusciutu pe’ tuttu lu regnu, tandu nemicu miu, tandu m’arrendu,
quandu la testa mia sàgghja a la ‘ntinna (Sono Calabrese e Calabrese resto, sono conosciuto per tutto il
regno, perciò, nemico mio, mi arrendo solo quando la mia testa finisce appesa
ad una antenna, ad un tronco d’albero). Meritano
infine la dovuta attenzione anche i numerosissimi modi di dire popolari. «’U
vecchju ‘n casa!», ad esempio, che significa «Il vecchio in casa». Si
riferisce, particolarmente alla persona giovanissima; al ragazzo che, nel
parlare, spesso fa uso di parole sagge, attraverso le quali si denota che ha
un nonno dentro casa, prodigo di insegnamenti. E
già, gli anziani. Lo dicevano all’inizio: la saggezza è il loro patrimonio. E
ogni qualvolta che un anziano se ne va, è una vera biblioteca che si chiude. (Vincenzo Pitaro, su «I CALABRESI NEL MONDO», Rivista della Giunta Regionale della Calabria – Novembre 2004) |
|
|
©
Copyright by Vincenzo Pitaro All rights reserved ™ International copyright
secured |
||